
Legge di bilancio 2026 e riforme del mattone: la guida tecnica dello studio 3Dr tra fisco e cantieri
La legge 30 dicembre 2025, n. 199, definisce il nuovo assetto per il settore edilizio
Home » Architettura

La legge 30 dicembre 2025, n. 199, definisce il nuovo assetto per il settore edilizio

Quanto costa una CILA?” È la prima domanda che ogni cliente si pone, ed è
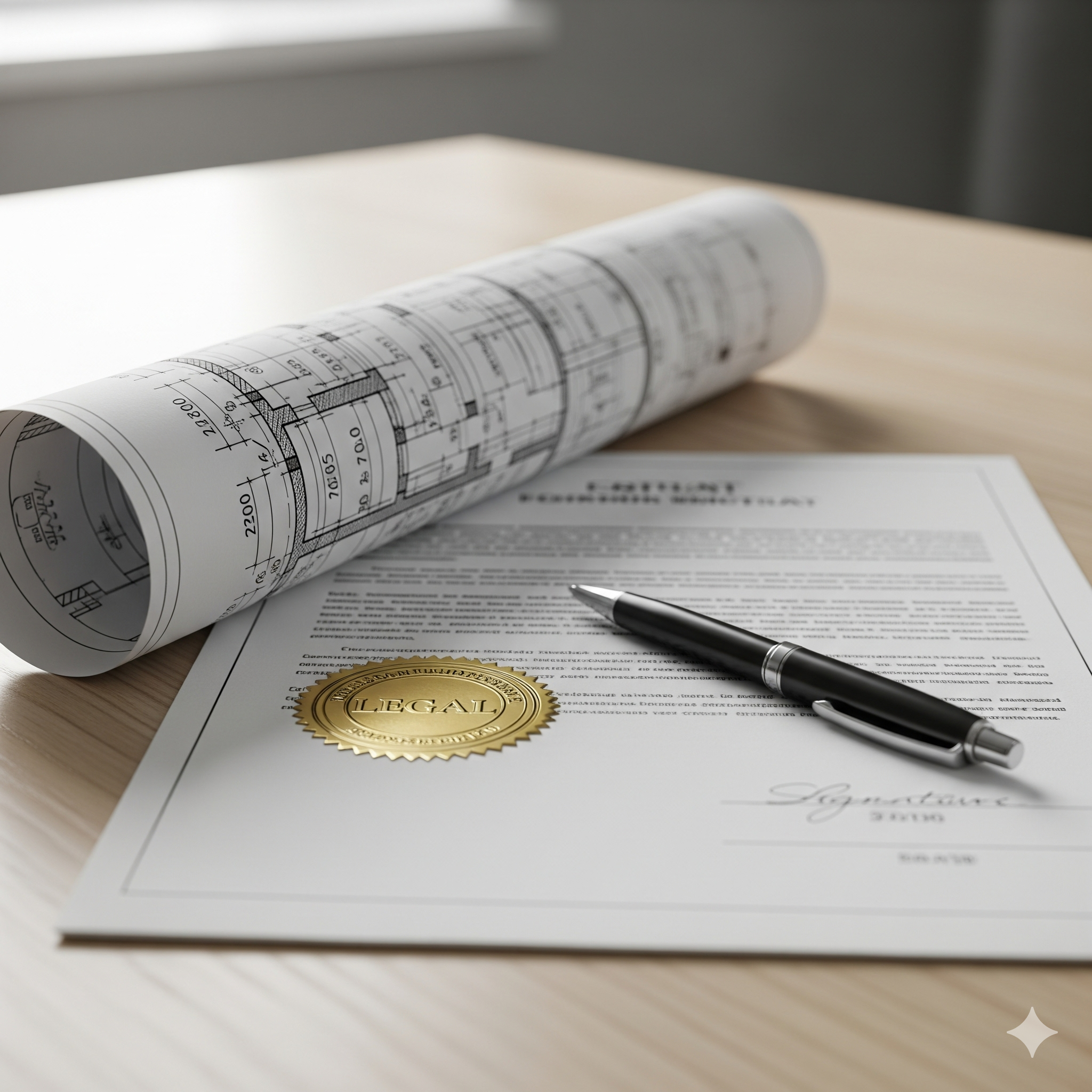
La compravendita immobiliare in Italia, un momento cruciale nella vita di un individuo o di

Il recente Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024, convertito in Legge n. 105/2024) ha profondamente

Quando si parla di bagni, l’Italia si distingue per una peculiarità che spesso sorprende i

Il lastrico solare rappresenta la superficie sommitale piana dell’edificio, funge da copertura per l’intero fabbricato

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto modifiche sostanziali al sistema delle

Il Superbonus 110%, introdotto nel Decreto Rilancio del 2020, ha rappresentato un’opportunità unica per l’Italia

Nel panorama legislativo italiano, la Legge n. 765 del 1967, comunemente nota come Legge Ponte,

La servitù di passaggio è un diritto reale di godimento che consente al proprietario di

Il Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è un fondamentale corpus
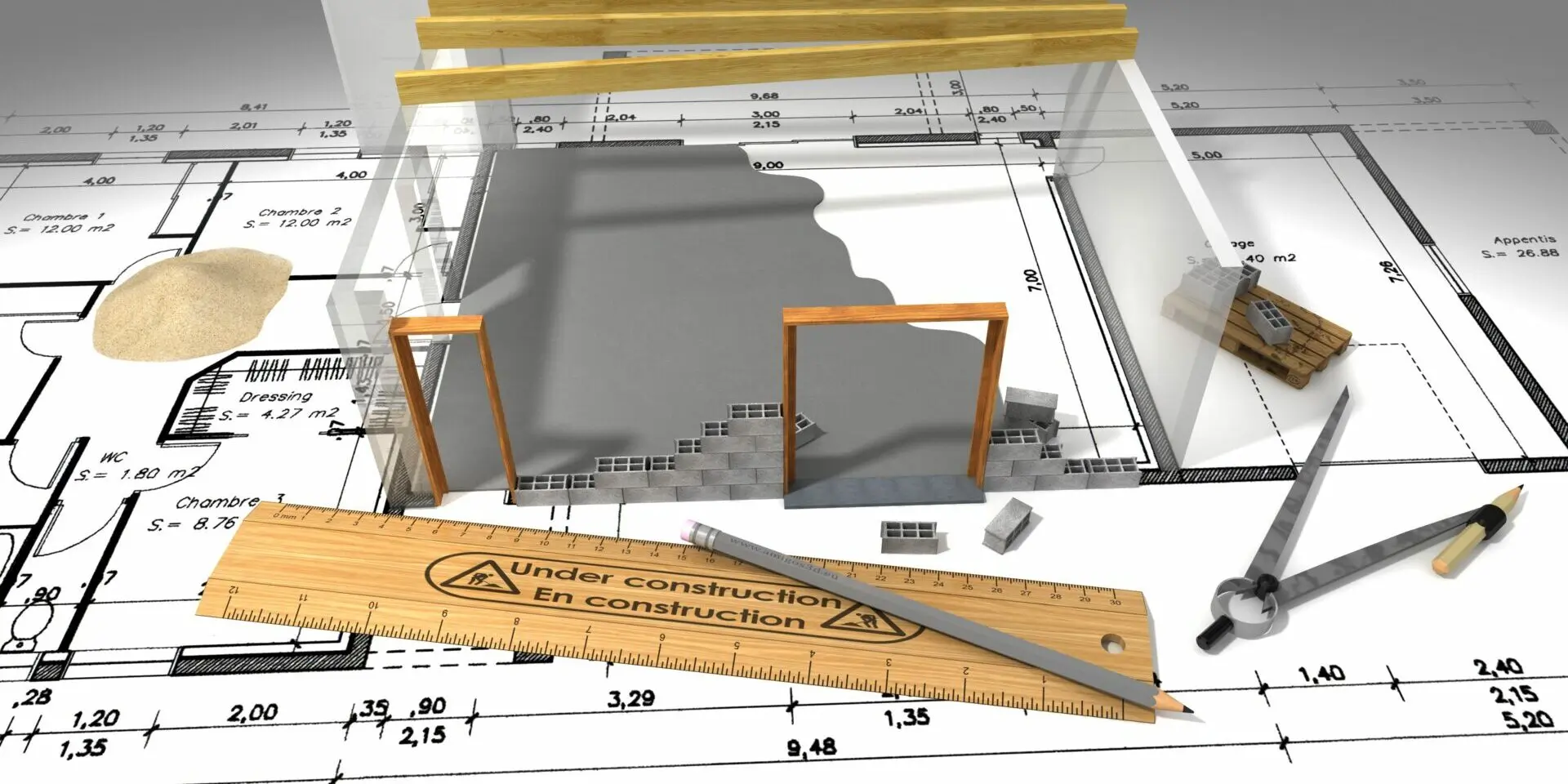
La ricerca della documentazione tecnica che attesti la regolarità urbanistico-edilizia di un immobile può risultare

Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 10 del 1977, il processo di rilascio del

Il Salone Internazionale del Mobile di Milano si appresta a inaugurare la sua 62esima edizione,

Il Durc di congruità dell’incidenza della manodopera, emanato attraverso l’articolo 8 comma 10-bis del Decreto

Il caos legato al Superbonus 110% continua a tenere banco. Dopo lo stop alle cessioni

La proroga del Superbonus 110% al 2024 è una misura importante per promuovere l’efficientamento energetico

Il legno utilizzato nelle strutture deve soddisfare requisiti di resistenza, durabilità e sicurezza, il legno

Il Superbonus 110%, la maxi-detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica e antisismica, è stata

Quando si ricerca “certificazione APE” su Google, è facile essere tentati da prezzi incredibilmente bassi

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiari dettagli sul Superbonus 2023, volto a stimolare l’edilizia post-pandemica.

La progettazione oculata, l’analisi energetica approfondita e la considerazione degli impianti e dell’interior design sono

Nell’interior design, l’uso di marmi, graniti, pietre naturali e pietre artificiali offre una vasta gamma

Il legame tra graphic design e interior design deriva dal loro scopo comune di creare

Ilse Crawford è riconosciuta a livello internazionale come una delle principali figure nel campo del

India Mahdavi è considerata una delle designer d’interni più influenti e riconosciute a livello internazionale.

David Rockwell è una figura influente nel campo dell’architettura e del design, con una carriera

Kelly Hoppen è una figura influente nel campo del design e continua a essere una

Karim Rashid ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera, ed è

Marcel Wanders è considerato uno dei designer più influenti e provocatori della sua generazione. Ha

Tom Dixon ha raggiunto la fama grazie al suo talento, alla sua creatività e al

Patricia Urquiola è una rinomata designer e architetta spagnola. Nata il 17 maggio 1961 a

Philippe Starck è un famoso designer e architetto francese, riconosciuto a livello internazionale per la

Kelly Wearstler è una famosa designer di interni e architetta statunitense. È nota per il

Alcuni degli Interior Design che hanno fatto la differenza degli anni 2000. Ognuno di loro

La creazione di un sito web richiede competenze tecniche, grafiche e, soprattutto, un’attenzione particolare al

Calcolare il bilancio energetico negli edifici è uno strumento fondamentale per identificare inefficienze, risparmiare energia,

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10606/2014, ha confermato la decisione della Corte

L’articolo sottolinea che questi sono solo alcuni degli stili di design d’interni più comuni e

La progettazione di sistemi illumino-tecnici è il processo di sviluppo e pianificazione di sistemi di

Il cambio di destinazione d’uso si riferisce alla modifica della funzione principale di un edificio

L’armocromia è una disciplina che studia la relazione tra i colori e le persone, e

L’articolo discute l’efficacia dei bonus edilizi come meccanismo di detrazione fiscale per incentivare l’economia, in

Il testo evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti affidabili per la certificazione energetica degli immobili,

Spesso mi capita di sentire persone che si affidano alla visura catastale per identificare la

La diagnosi energetica è obbligatoria in determinati casi, come per gli edifici residenziali che